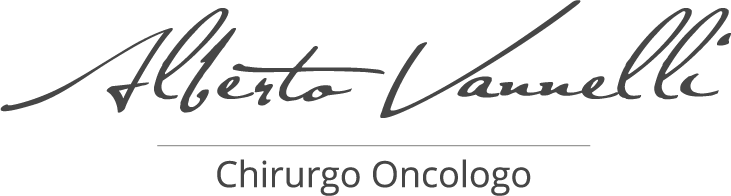Pippo Baudo si è spento sabato 16 agosto 2025; figura iconica della televisione italiana, fu non solo creatore di spettacoli ma insuperabile talent scout tanto che alla sua scomparsa il tormentone di chi gli rende omaggio è quello che lui stesso aveva lanciato: ''l'ho inventato io''. Tra le tante non possiamo dimenticare l'importante innovazione in oncologia.
“Il cancro era un tabù, non se ne parlava in famiglia e tantomeno in televisione”. Con queste parole, diversi storici della comunicazione sanitaria hanno riassunto l’Italia degli anni ’80 e primi ’90. Poi, nel 1995, qualcosa cambiò: Pippo Baudo, il volto più popolare della RAI, portò la ricerca oncologica nel cuore delle case degli italiani con il format "Storie al microscopio".
Da quel momento, nulla fu più come prima.
Prima di Pippo Baudo: l’immagine iniziale di AIRC
Fondata nel 1965, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) era un’istituzione seria e autorevole, ma percepita come distante. Le campagne degli anni ’70 e ’80 erano sobrie, con pochi volti noti e un linguaggio tecnico. L’obiettivo era raccogliere fondi per la ricerca, ma il pubblico rimaneva passivo. Il cancro era ancora una parola difficile da pronunciare.
1995: Storie al microscopio, la svolta
Baudo intuì che la scienza aveva bisogno di storie. “Non bastano i numeri, servono i volti e le emozioni”, disse presentando la prima edizione. Con "Storie al microscopio"; i ricercatori raccontavano i progressi, mentre i pazienti testimoniavano la loro esperienza. La televisione, mezzo unificante dell’Italia di quegli anni, divenne veicolo di consapevolezza e solidarietà. I risultati furono immediati: secondo i dati AIRC, nella seconda metà degli anni ’90 la raccolta fondi aumentò sensibilmente e il tema della prevenzione entrò stabilmente nel dibattito pubblico.
Dal piccolo schermo ai social
Con l’inizio degli anni 2000, la televisione restò centrale: le maratone RAI, le campagne come #NastroRosa e l’Azalea della Ricerca consolidarono l’immagine di AIRC. Ma è con i social media che il messaggio oncologico ha raggiunto nuovi orizzonti. Facebook, Instagram e TikTok hanno permesso di rivolgersi a pubblici differenti, con linguaggi personalizzati: dai video dei ricercatori, alle testimonianze dei pazienti, fino alle campagne virali che hanno moltiplicato la partecipazione.
��
I numeri parlano chiaro: nel 2000 in Italia vivevano con una diagnosi di tumore circa 1, milioni di persone. Oggi, nel 2024, sono oltre 3,7 milioni (AIRC, 2024). Non è solo un aumento legato all’invecchiamento della popolazione, ma soprattutto alla maggiore sopravvivenza e alla diffusione della diagnosi precoce.
Conclusione
La storia di AIRC e della comunicazione oncologica italiana è anche la storia di un cambiamento culturale. Da malattia innominabile a tema collettivo, il cancro è entrato nel discorso pubblico grazie alla forza della televisione e all’intuizione di Pippo Baudo. Oggi i social hanno reso il messaggio più capillare e interattivo, ma la sfida resta la stessa: mantenere credibilità scientifica senza rinunciare al linguaggio delle emozioni. In questo senso, "Storie al microscopio" rimane una pietra miliare.
Riferimenti
- AIRC. I numeri del cancro in Italia 2024. Disponibile su: https://www.airc.it
- ISTAT. Demografia e salute della popolazione italiana, rapporti 2000–2024.
- Fondazione Veronesi. Tumori in Italia 2024: più guarigioni e calo della mortalità nei
- giovani.
- Rai Teche. Archivio programmi televisivi: "Storie al microscopio", 1995.
- BMJ – BMC Cancer. Trends in cancer mortality in Italy, 1995–2021.